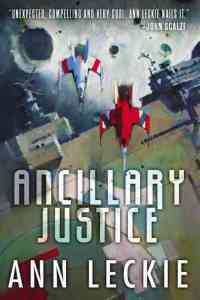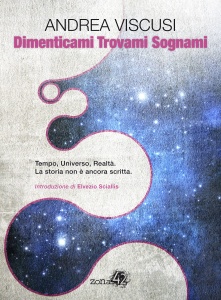E insomma eccoci qui, torniamo sul luogo del delitto. L’ultima volta avevo recensito proprio Angeli di Plastica; nel baratro di tempo che è passato ho avuto modo di conoscere meglio Emanuela Valentini e di pensare di approfondire qualche tema con lei. E dunque eccoci. E attenzione, non saremo brevi… 😉
E insomma eccoci qui, torniamo sul luogo del delitto. L’ultima volta avevo recensito proprio Angeli di Plastica; nel baratro di tempo che è passato ho avuto modo di conoscere meglio Emanuela Valentini e di pensare di approfondire qualche tema con lei. E dunque eccoci. E attenzione, non saremo brevi… 😉
Emanuela Valentini e’ di sicuro un’autrice atipica nel quadro del fantastico italiano. In primo luogo per la distanza davvero minima che sembra porre tra ciò che scrive e ciò che sente, così che narrare sembra essere per lei più un flusso di coscienza che una storia di struttura tradizionale; sia per la solarità che emerge nel suo pubblico da social, sempre estremamente aperto e mai musone. Insomma, come arrivare a un passo del premio Urania e non tirarsela minimamente. Sei d’accordo, Manu, con questo psicologismo da collega autore al momento in animazione sospesa?
Intanto ti ringrazio per avermi definito atipica, non mi è mai piaciuto essere tipica e in effetti mi riesce male, quando cerco di “tipicizzarmi” divento invisibile. Per quanto riguarda la genesi del mio essere autrice, non so capire se la fusione psicologica di cui parli dipenda dalla mia formazione o non magari da una propensione o sensibilità personali, ma per certo vivo davvero il narrare come flusso di coscienza anche laddove tenti di raccontare una storia che non abbia nulla a che vedere con me e con le mie esperienze personali. In ogni caso scrivo ciò che sento. Questa cosa, che da un lato può favorire la sfera emotiva degli scritti, dall’altro rischia di farmi ripetere sempre gli stessi schemi in storie tra di loro molto diverse e la prospettiva non mi aggrada. Sto lavorando al distacco, ma quello sano. Non credo sarei mai in grado di scrivere qualcosa su commissione. E per qualcosa intendo qualcosa di valido, che a scrivere qualcosa sono capaci tutti. O quasi.
Sono molto contenta anche del secondo punto che esprimi: io amo moltissimo la comunicazione per immagini, per slang, per provocazioni. Il social permette tutto questo e io ci sguazzo dentro con grande soddisfazione. Magari avessi avuto il social a quattordici anni, a quindici, a sedici: quando riempivo quaderni di storie macabre e poesie autodistruttive o magiche. Magari avessi avuto prima la possibilità di comunicare la mia vera me attraverso fotografie di foglie o selfie buffi, ma soprattutto attraverso la scrittura! Eeeeh, vabbè. Approfitto ora e recupero il tempo perso con un uso vivace del social che a qualcuno dà fastidio ma ai più invece piace e la cosa mi diverte tanto.
Arrivare a un passo dal Premio Urania alla prima botta (primo tentativo) e non tirarsela minimamente? Ho gioito, mi sono auto incensata un attimo ma sono troppo severa con me stessa per tirarmela, anche per una splendida finale ambita da tanti. E sono troppo abituata a incassare sconfitte per arrabbiarmi e fare i capricci se non vinco. Quindi, mio caro, mi trovi perfettamente d’accordo con il tuo psicologismo da collega in animazione sospesa. Lavoro in ospedale da almeno un decennio ormai; ho controllato la tua cartella clinica… forse non te ne sei accorto ma ti hanno dimesso da un pezzo. Vedo anche che non hai fratture alle dita, quindi puoi riprendere a scrivere ok?
Ok, ok, anche se, come diceva quello, è la capa ca nunn’è bbona… Comunque grazie, è bello sentirsi dire che si è sani. Ma torniamo a te: tutti che ti chiedono, ma Mei è Manu, ma fino a che punto, ma magari è Manu psicotica, ma dicci… A me pare tu abbia costruito un personaggio autonomo con qualche pirotecnia tutta tua, come fanno un po’ tutti gli scrittori. Ma amandola moltissimo. Giusto?
Ma sì, ho costruito un personaggio autonomo e l’ho fatto involvere. In genere seguo uno schema parecchio classico circa l’arco esperienziale dei personaggi che alla fine capiscono meglio loro stessi e il mondo, migliorano, si redimono. Qui no. In Angeli di Plastica l’obiettivo era creare un personaggio che funzionasse all’inverso e cioè che riuscisse a dare progressivamente il peggio di sé nel corso della narrazione. Mentre scrivevo ho spesso avuto l’impressione di stare infarcendo Mei di un carattere violento del tutto gratuito, aspetto che poi, rileggendo si è smentito da sé. Ancora una volta, anche volendo esagerare, ho dato al personaggio tutte le attenuanti per il suo comportamento degenerante, cosa che in parte mi ha deluso perché l’intento iniziale era quello di creare un adorabile mostro ingestibile, dall’altra mi ha consolato perché in questo modo la storia ha assunto i connotati delle favole disperate, non solo quelli di un massacro annunciato. Mei è un personaggio dannato all’ennesima potenza, non posseduto da alcun demone se non dai propri squilibri affettivi e sociali. In fondo è una di noi. L’empatia con lei è stata da subito fortissima perché grazie a lei ho potuto sfogare rabbia sopita, delusione; reagire a roba del passato vissuta male, ho potuto vendicarmi di abusi mai assorbiti, ho avuto modo di mettere me e il lettore di fronte a quello che succede se ci si lascia andare. Se si supera la soglia. Lo so che non se ne sentiva il bisogno perché per farsi un’overdose di drama inconcepibile basta accendere i TG a qualsiasi orario, eppure è servito a me per canalizzare un flusso delusivo e alienante che mi stava divorando e ritrovare la grinta necessaria a ripartire. Mei mi ha di fatto aiutato a esorcizzare aspetti della mia emotività che trovano rimedio solo e soltanto nella scrittura, oltre ad avermi fatto divertire da matti.
Angeli di Plastica/Mei e’ scritto spesso di getto. Tu stessa ammetti di esserti lasciata prendere dai personaggi. Rischio insidiosissimo. Che ne pensi?
Sì, sì. Anche perché l’ho steso in un mese e mezzo o poco più. Più che scritto quel romanzo è stato vomitato, direi. Più che lasciata prendere la mano, però, mi sono fatta prendere il cuore. Gente come Tria avrebbe meritato una vita più dolce, normale: avrebbe meritato di andare a scuola e passare il pomeriggio in giardino con le amichette. Sauro, pure lui, non avrebbe forse meritato un’occasione? Lo avrei visto bene fare ingegneria o meglio ancora giurisprudenza all’Università. Ragazzo dall’intelligenza acuta e dal fortissimo senso della giustizia, avrebbe certo meritato di essere amato e curato. Dal suo canto Mei ha avuto dalla vita tutto sebbene a un costo altissimo. Il prezzo da pagare nel suo caso si è rivelato troppo al di sopra delle sue possibilità. La distruzione era inevitabile. North l’ho amato ma in maniera del tutto differente dagli altri: ho preferito serbare le distanze dalla sua sfera emotiva per mantenerne intatto il mistero profondo. L’ho dotato di una gelida dolcezza e di un universo interiore vastissimo e insondabile perché la storia, per la legge della compensazione, sentiva il bisogno di evadere dagli schemi brutali della trama e lui era l’unico personaggio utile allo scopo. Gli altri sono tutti attori, comparse più o meno importanti.
 Nemmeno tu alla fine hai saputo però resistere alle amare chimere della distopia. Ma ragazzi, come mai vi piace così tanto il postapocalittico?
Nemmeno tu alla fine hai saputo però resistere alle amare chimere della distopia. Ma ragazzi, come mai vi piace così tanto il postapocalittico?
La verità è che non avevo tempo per studiare un momento storico congeniale e un’ambientazione originale per la storia. Alla fine le dinamiche post apocalisse sono clichè sempre affascinanti e potenzialmente semplici da gestire dal narratore che non ha tempo. In questo caso ho dovuto fare una scelta e ho deciso di approfondire gli psicologismi dei personaggi principali a discapito dello sfondo socio politico che rimane volutamente sfocato.
Non sarà anche perché oggi il mondo sembra così apparentemente controllato, tutto a portata di app, che l’idea è di sedere sulla polveriera e voi, puff, provate a vedere come si starebbe dopo lo scoppio?
Anche. A me la polveriera affascina da sempre. Ogni volta che mi approccio a una storia dallo sfondo esploso mi chiedo come vivano i personaggi, come si sentano dentro e quale sia la loro visione e percezione del mondo e soprattutto del futuro, se ce l’hanno. Alla fine non ce ne rendiamo conto ma tutte le nostre certezze scivolano su un filo molto sottile. Basterebbe un crash nel sistema informatico per mandare nel caos la nostra quieta normalità, figuriamoci l’apocalisse. E comunque è un argomento sempre pieno di sfumature interessanti soprattutto sui piani temporali. L’apocalisse può fare sprofondare l’umanità in un nuovo medioevo, in una nuova età primitiva e quindi in un già visto reinterpretabile oppure proiettare i sopravvissuti in situazioni ancora tutte da inventare. Evviva! Boom!
Ciò che ci porta al genere. Brutalmente, la sf italiana ha un futuro oppure ogni anno a Fiuggi si consuma l’ennesimo Mardi Gras del vorrei ma non posso?
Io sto lavorando con chi già lo fa da tempo affinchè Fiuggi sia un vivaio di idee e di voci nuove, di progetti, di futuro. Del voglio e posso. Io lavoro per vedere il buon fantastico sugli scaffali delle librerie. Il genere esiste e non è sminuente come taluni credono o cercano di lasciare intendere. Non ci sono bei generi o brutti generi, esistono storie scritte bene e storie scritte male. Mi piace quando è utile a classificare, mi piace meno quando serve a svilire e bistrattare. Molto spesso negli ultimi anni mi sono trovata a rammaricarmi davanti a frasi tipo: “non pubblico fantastico” o “il fantastico non va, non vende” o ancora “no, la fantascienza non mi piace, non mi interesso di astronavi” e, anche, “i gialli non li capisco, preferisco roba più generica e filmica tipo i thriller”. EH?! Quanta ignoranza si nasconde dietro simili affermazioni? Come si fa a disprezzare un intero genere, peraltro a sua volta divisibile in numerosi sottogeneri come il fantastico? Come si fa a dichiarare pubblicamente su un social network (come ultimamente ha fatto un editorino che al mio dissentire mi ha bannato) che il fantastico italiano fa cagare e che è la vergogna della narrativa internazionale? Come si fa a dire: mi fa schifo la fantascienza: non so nulla di alieni e astronavi, come se alieni e astronavi fossero LA FANTASCIENZA? Il fantastico è un genere antico, potente e nobile. È letteratura sottile. Personalmente adoro i generi letterari, mi piace spaziare, mescolarli, studiarli. Resto esterrefatta di fronte a esternazioni tipo “noi si pubblica solo narrativa generale”, e che sarebbe ‘sta narrativa generale? Qual è la storia che non è ascrivibile in nessun genere? Devo ancora trovarla. E come mai se Ammaniti scrive “Anna” una storia chiaramente classificabile nel macrogenere della fantascienza, questa parola viene evitata come la peste dai giornali e il romanzo presentato come particolare, una favola, qualcosa di boh, diverso, nato da un capriccio dell’autore? No, è simply fantascienza. E diciamolo però.
Diciamolo, dai.
E come mai lui la può pubblicare nell’altissimo mondo delle big e autori che la scrivono da decenni, autori geniali che hanno dedicato la vita alla fantascienza sono a vendere i loro libri alle fiere, poco più che sconosciuti? E come mai la narrativa di genere che trovi in libreria è al 98% comprata all’estero? Le nostre case editrici non si fidano degli autori italiani? Non investono in noi, e perché? Ma ci conoscono? Ci cercano? Come mai da noi si aspettano la “narrativa generale”? E devo ancora capire come mai questa cosiddetta narrativa generale sembra essere la deriva più gettonata oggi negli ambienti letterari che “contano”, mentre la narrativa di genere (vera e propria fucina di storie e di voci) resta ghettizzata come materia per pochi, per fissati (grazie a questo razzismo acquisisce anche un peso specifico maggiore eh, una nota intellettuale che non sempre è reale ma spesso sì). Non è la storia che conta? Non sono le emozioni che suscita a fare la differenza? Non è la voce interessante di un autore a dover attrarre l’attenzione dell’editoria grossa? No. Oggi se vuoi avere una chance con case editrici big devi saper presentare la tua opera con furbizia, farla passare il più possibile per “normale”, per narrativa generale con qualche sfumatura di giallo o thriller ma non ti azzardare a metterci il surreale. Io questa deriva preferisco chiamarla con il proprio nome: narrativa da intrattenimento, e non avrebbe niente di cui vergognarsi se solo venisse dato spazio anche a qualcosa di diverso da fiori e api e amori che vanno e che vengono e bacchette di cannella. Se solo si potesse scegliere cosa e chi leggere. A tutti piace leggere il libretto leggero e divertente sotto l’ombrellone e forse per molti autori è anche divertente scriverle, le storie da ombrellone: peccato che oggi questo genere che spacciano per narrativa generale (da non confondersi con la vera narrativa e cioè Murakami, Roth, Benni, Baricco, sì, Baricco, lo stesso Cotroneo e molti altri) è quello che riempie per intero gli scaffali delle librerie nel reparto novità!
Stiamo arrivando al punto…
E a causa di questo impoverimento del livello si fa sempre più fatica a parlare persino di narrativa pop perché poi i conservatori pensano che gli vuoi propinare la storiella da ombrellone e invece tu stai solo cercando di trovare il giusto compromesso tra quella e Roth, appunto. Ma tra l’ombrellone e Roth oggi non ci trovi niente, perché la narrativa bella di genere in libreria non arriva mica e quindi sei costretto a scegliere tra il nulla patinato servito come l’esordio dell’anno e i grandissimi impegnativi. E che palle. È pressochè imposssibile oggi trovare in libreria qualcosa di nuovo che sia anche veramente valido e interessante da leggere tra i vari grandissimi e tra i classici intramontabili. Buono per gli ignoranti che leggono tre libri l’anno. Buono per gli esordientielli che cavalcano le onde del momento e che per puro caso si ritrovano sullo scaffale con un marchione sul petto e poi spariscono alla prima mareggiata. Mortale per i lettori affamati di belle storie e nuove voci che abbiano da dire qualcosa, non che propongano storielle copia incollate da altre che hanno avuto successo negli States. Ricordo che Neil Gaiman in Italia vende pochissimo e così romanzi particolari e intensi (non per forza iper impegnativi!) come Il Miniaturista o la ladra di libri che ha venduto migliaia di copie SOLO dopo l’uscita del film (peccato che il romanzo fosse uscito anni prima e passato in sordina), sempre più rari da trovare in libreria; trovo tutto questo assurdo, ma soprattutto trovo ridicolo che magnifici lavori di genere NOSTRANI, con nulla da invidiare agli stranieri stravenduti, in libreria non ci arriveranno mai. Prova a presentarti a una big con un magnifico romanzo sincero, di fantascienza o mystery o ghost story, e vedi come ti mandano a casa a passi lunghi e ben distesi. Presenta invece una storiellina TIPO quelle di John Green o TIPO Chocolat della Harris ma moooolto più diluita eh, o ancora TIPO Hunger Games o Maze Runner e vedi che forse una chance l’avrai. Questa è l’epoca del già visto e del già sentito. Se volete trovare l’originalità, il genio, l’invenzione, la ricerca, dovete frugare gli stand nelle fiere della piccola editoria e nelle convention di narrativa fantastica. Non è questione di genere, è questione di assenza totale di scouting serio e trascuratezza dei testi che, già banali, arrivano in libreria pure pieni di refusi. Che succede all’editoria italiana? Esiste ancora chi cerca belle storie o anche qui siamo su X Factor con le starlettine che hanno la durata di una stagione?
Sf in Italia significa anche il rapporto con un editore. Siamo sempre ai soliti pionieri o a tua scelta kamikaze, oppure si muove qualcosa?
Ma in linea generale siamo sempre lì. Pochissimi pionieri kamikaze. Si resta in attesa di grossi partners che aprano spiragli al fantastico italiano facendo serie e accurate selezioni. Che dire? Speriamo bene.
La mia impressione è che fra te, Viscusi e Vietti, le tre V, andando in ordine crescente di età, almeno credo, qualcosa di nuovo ci sia eccome. Una scrittura che in qualche modo viva anche delle vostre, delle tue esperienze su rete?
 Mi rende felice essere compresa nella breve lista delle potenziali novità nel panorama nazionale. Io non dubito che vi siano voci interessantissime da approfondire e non nascondo che la tendenza negli ultimi lavori che ho letto sia quella di riportare nella narrativa i vizi e le virtù del mondo dei media, le contraddizioni generate dai social e in qualche maniera il potere del supporto tecnologico. Personalmente lo faccio, non come presa di posizione ma semplice ispirazione. In fondo è giusto; uno scrittore deve saper raccontare il proprio tempo, affondare la lama nei difetti e nelle cicatrici sociali e incensare quel poco di positivo che riesce a trovare, se c’è. Anche per questo ho ridotto la mia produzione di racconti steampunk. Adesso voglio parlare del presente.
Mi rende felice essere compresa nella breve lista delle potenziali novità nel panorama nazionale. Io non dubito che vi siano voci interessantissime da approfondire e non nascondo che la tendenza negli ultimi lavori che ho letto sia quella di riportare nella narrativa i vizi e le virtù del mondo dei media, le contraddizioni generate dai social e in qualche maniera il potere del supporto tecnologico. Personalmente lo faccio, non come presa di posizione ma semplice ispirazione. In fondo è giusto; uno scrittore deve saper raccontare il proprio tempo, affondare la lama nei difetti e nelle cicatrici sociali e incensare quel poco di positivo che riesce a trovare, se c’è. Anche per questo ho ridotto la mia produzione di racconti steampunk. Adesso voglio parlare del presente.
Rete, luogo poco adatto alle persone sensibili. O sbaglio?
Adattissimo, a mio avviso, nonostante esista il rischio, per talune personalità particolarmente fragili, di cadere in derive voyeuristiche e pseudo maniacali o di abuso e overdose del mezzo tecnologico. Io parlo da persona ipersensibile. Per me confrontarmi con una community virtuale è stato inzialmente traumatico ma poi la paura si è tradotta in entusiasmo da scoperta e in esplorazione di nuovi modi di comunicare non solo stati d’animo ma anche messaggi politici, etici, letterari, buffi fino a diventare parte integrante del mio lavoro di narratrice. Negli ultimi due anni il social è stato per me una famiglia allargata che spesso mi ha impedito di sentirmi isolata non solo nel vivere gli impegni legati alla narrativa ma anche a un livello più umano e personale. Sul social ho conosciuto alcune tra le persone che ho poi incontrato nella realtà e che oggi fanno parte della mia vita! Rispetto chi ancora guarda il social come una macchina del demonio e ricordo che c’è la misura per tutto, (hanno ragione, non bisogna diventare dipendenti blablabla – così ho fatto la mia parte socialmente utile). Non rispetto invece chi usa il social per scrivere cazzate dalla mattina alla sera, ecco, quella è l’interazione che nella vita reale come in quella virtuale non mi serve a niente.
Detto tra noi che non ci sente nessuno, paga di più dire sempre ciò che si pensa o fare il pescione in barile?
Il pescione in barile campa sicuramente più a lungo e più facile dei nuotatori da fogna come me e te, Giampiè, parlamose chiaro. Ma a me di girare in cerchio dentro un barile non va per niente e, per dirla tutta, meno che mai di finire cotta in forno quando non servo più. Preferisco la schiettezza pericolosa della fogna, sicuramente ci incontri gente parecchio più interessante dei pescioni felicioni nei loro barili/teglie imburrate pronte a essere inserite a 200°. 180° se ventilato.
Torniamo alle belle lettere. Dobbiamo aspettarci uno stile diverso e magari più posato nel futuro? E per che cosa?
Veramente l’eccezione è Angeli di Plastica. Io in genere non scrivo mica così. Chi ha trovato barocco Angeli di Plastica non ha idea dei picchi di lirismo che posso raggiungere nella mia prosa tradizionale. Sto lavorando per asciugare lo stile però eh, e per fare goal senza troppi virtuosismi in campo che sono tanto belli ma poi dicono che vuoi fare vedere quanto sei brava. Non sia mai!
Tu e Lorenzo Crescentini ci avete pure regalato una importante pubblicazione all’estero. Obiettivo perseguito scientemente o tentativo casuale?
Che gioia! Obiettivo perseguito con impegno da Lorenzo che ha personalmente cercato contatti e tradotto la prima bozza del racconto scritto insieme. Da parte mia c’è stata una deliziosa assenza di iniziativa che ammetto senza pudore a favore di quelle personalità vincenti che hanno pensato bene di complimentarsi in privato con Lorenzo ma non con me. Però ho fatto riti propiziatori perché ci prendessero in Clarkesworld, eh, ma non so se questo vale.
Sf italiana all’estero: la storia di Mei potrebbe avere possibilità?
Secondo me sì! Devo trovare un traduttore e soprattutto i soldi per pagarlo, che quel romanzo è lunghissimo. In questo momento ho in traduzione Diesel Arcadia (Premio Robot) altra storia che vorrei vedere pubblicata su qualche bella rivistona estera! Yeah!
Hai mai pensato che potrebbe venirne fuori anche una splendida mini serie TV?
Sarebbe il massimo. E in questo senso non saprei come muovermi…
Tu sai benissimo che siamo gente che non se la prende per bazzecole del genere … Ahem… Ma ecco, a parte Tonani cui hai già detto di dovere molto, verso quale autore italiano di sf (possibilmente vivo e di cattivo carattere) pensi di poter essere debitrice di ispirazione?
Autori italiani vivi con un pessimo carattere a cui devo molto in termini di ispirazione e motivazione? Facile: Giampietro Stocco e Fabio Carta.
Senza dimenticare personalità che lavorano nell’ambito della narrativa, amici, professionisti di grande competenza che hanno vivacizzato le mie esperienze con consigli e deduzioni: in particolare ringrazio Salvatore Proietti, Silvio Sosio, Sandrone Dazieri, Giorgio Raffaelli. Thanks!
Personalmente non amo molto il genere steampunk, ma la connotazione “sporca” (che certo si deve a Dario Tonani e che io preferisco definire “emozionale” ) che caratterizza la tua versione del genere e’ un qualcosa di diverso, che ci libera dalle tristissime fiere dei gentiluomini straordinari e dai troppi dirigibili gonfiati col gas naturale. Detto ciò dove e’ diretta l’aeronave di Manu?
Noooo io scrivo questo mio steampunk da prima di conoscere il Darione. Ho sempre dato allo steampunk una connotazione molto personale perché lo sento un genere che mi appartiene per qualche motivo a me sconosciuto: probabilmente in una vita precedente sono stata un’aeronauta come la mia Ophelia, o la redattrice di feuilleton in qualche rivista letteraria di fine Ottocento, chissà. O semplicemente da ragazzina mi sono drogata di Dickens, Verne e Conan Doyle.
Dove è diretta la mia aeronave? Bella domanda carica di nostalgia preventiva. Mi becchi nel bel mezzo di una virata che mi porterà probabilmente molto, molto lontano da questi siti, ma farò in modo di esserci, di fare tappa ogni tanto, di mantenere un filo diretto con il mio grande, infinito amore: il genere fantastico e chi, come me, lo apprezza e lo vive da lettore e ancora di più da narratore.
 Grazie per l’ospitalità.
Grazie per l’ospitalità.
 Distopia come modalità per scongiurare un futuro prossimo che ci spaventa, come abbiamo visto in questi mesi con il Covid-19 o altro?
Distopia come modalità per scongiurare un futuro prossimo che ci spaventa, come abbiamo visto in questi mesi con il Covid-19 o altro?




 Fate come allegoria di femminilità tormentata: quante volte gli uomini pensano alla donna come a un’entità quasi magica? Quante volte questa corrente selvaggia di magia e vitalità finisce per essere imbrigliata e forzata in rapporti pesanti e senza futuro dove l’unica regola finisce per essere la violenza? E senza arrivare a questi estremi, quante volte, quanti uomini non si sono voluti rassegnare all’idea che le donne della loro vita fossero persone proprio come loro, desiderose di dignità e rispetto, e le hanno comunque snaturate sfruttando il loro amore, brutalizzandone l’anima? Il possesso che uccide l’amore.
Fate come allegoria di femminilità tormentata: quante volte gli uomini pensano alla donna come a un’entità quasi magica? Quante volte questa corrente selvaggia di magia e vitalità finisce per essere imbrigliata e forzata in rapporti pesanti e senza futuro dove l’unica regola finisce per essere la violenza? E senza arrivare a questi estremi, quante volte, quanti uomini non si sono voluti rassegnare all’idea che le donne della loro vita fossero persone proprio come loro, desiderose di dignità e rispetto, e le hanno comunque snaturate sfruttando il loro amore, brutalizzandone l’anima? Il possesso che uccide l’amore.